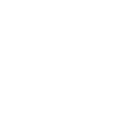L'introduzione di Lelio Basso all'Antologia Scritti Politici
da Una Rosa nel cuore 1.3 La Rosa e la tonaca (pp. 13-14)
Uno degli ultimi libri che portai a casa, prima che mio padre, terminato il periodo di “zona disagiata” potesse essere, finalmente, trasferito per ritornare a Napoli, era proprio l’antologia degli scritti di Rosa Luxemburg curata da Lelio Basso, pubblicata nel 1967 dagli Editori Riuniti. Un libro che, ma l’ho scoperto soltanto quasi cinquanta anni dopo leggendo l’articolo di Luciana Castellina scritto in occasione del centenario dell’assassinio di Rosa Luxemburg, era stato all’origine dell’intera proposta politica del gruppo del Manifesto, al quale avevo aderito di istinto, senza alcuna preventiva analisi politico-ideologica per la quale, d’altra parte, mi sarebbero mancati i fondamentali. Luciana Castellina ricorda che “a portarcela fu soprattutto Lelio Basso, questo singolare socialista di sinistra che, con la sua rivista Problemi del Socialismo, aveva già e non poco contribuito ad allargarci la testa. Lo fece pubblicando, con una sua introduzione, un illuminante volume di scritti di Rosa Luxemburg che aiutò la ricerca che i compagni che poi dettero vita al Manifesto, Magri e Rossanda in particolare, erano già andati conducendo sulla tematica consiliare e sul rapporto spontaneismo/partito. Che è poi il tormentato problema della coscienza di classe: se nasca dalla, e nella prassi della lotta, o se sia portata, e come, dall’esterno”. Quindi, mentre io provavo a capirci di più e a mettere ordine nella tempesta di concetti ed emozioni con cui, ancora adolescente, cercavo di definire una mia identità politica e sociale, a via Tomacelli o a casa di Lucio Magri, in piazza del Grillo, c’era chi leggeva, studiava, approfondiva e provava ad attualizzare il pensiero di Rosa, partendo dal medesimo testo, dalle medesime intuizioni.
da Una Rosa nel cuore 1.4 La Rosa rossa (pp. 15-17)
L’introduzione di Lelio Basso all’antologia ricorda le ultime parole di Lenin in merito alla necessità di pubblicare e studiare le opere di Rosa Luxemburg e manifesta l’intento di “offrire uno strumento attuale, perfettamente valido ancora oggi [nel 1967] per l’elaborazione e l’approfondimento di una strategia di lotta del movimento operaio. Perfettamente attuale ancora oggi, anzi sempre più attuale a misura che i militanti più seri ed impegnati, spezzate le catene del dogmatismo […] riprendano contatto con la sorgente viva del pensiero marxista riscoprendone l’inesauribile ricchezza”.
In un altro passaggio, Lelio Basso si avvale di una citazione di Gilbert Badia: “Rosa Luxemburg è stata spesso presentata come l’alfiere di un socialismo che, al contrario del socialismo autoritario che ha conosciuto l’URSS sotto Stalin, unirebbe la presa di possesso dei mezzi di produzione da parte del proletariato alla libertà individuale. In realtà essa non faceva che riprendere e proseguire la battaglia di Marx: il trionfo del socialismo implica il pieno dispiegamento dell’individuo”.
Già leggendo queste prime righe stavo trovando la risposta che cercavo ai miei dubbi, alle mie perplessità, alla mia evidente difficoltà nel riconoscermi in un’idea di comunismo che, sia nella versione russa che in quella cinese, non mi convinceva, non poteva rappresentare il mio orizzonte, la mia prospettiva di vita. Insomma, non mi sembrava proprio che russi e cinesi, bulgari o albanesi (senza parlare di Praga), se la passassero meglio di noi. E un poco mi vergognavo nel pensare che, se proprio avessi dovuto avere un modello di società da imitare, avrei guardato ai paesi del Nord Europa, alla Svezia dei servizi sociali e della libertà sessuale o alla Danimarca di Christiania. Un modello che, con le dovute differenze, per i comunisti italiani era rappresentato dall’intramontabile mito dell’Emilia Romagna. Ecco, allora, come le parole di Lelio Basso potessero risultare familiari, compatibili con le mie aspettative: “La società socialista è, per la Luxemburg, una collettività di uomini responsabili che si autogovernano ed è appunto questa interpretazione del socialismo che deriva direttamente da Marx […] Perciò l’idea kautskiano-leninista che la coscienza di classe possa esser data al proletariato dall’esterno, che il socialismo possa esser costruito dall’alto, dopo la presa del potere, sono idee estranee al marxismo. Ed è viceversa all’interno del marxismo la concezione luxemburghiana del rapporto movimento-organizzazione: quel che conta è il movimento in funzione dello scopo finale, rivoluzionario, cioè un movimento che implica insieme trasformazione della società e degli uomini, mentre le forme organizzative e di direzione devono essere subordinate alle esigenze del movimento e dunque si plasmano e si correggono secondo le sue necessità”.
Poi, un’affermazione che sarebbe risultata un frullato di profezia autoavverante e di giustificazione consolatoria per le tante, troppe sconfitte che avrebbero accompagnato i miei anni a seguire: “È in questo senso che la Luxemburg dice che le rivoluzioni socialiste sono sempre premature e le sconfitte inevitabili”. In conclusione, Lelio Basso mette in chiaro che: “il punto centrale della visione socialista di Rosa Luxemburg come di Marx è la liberazione dell’uomo da ogni forma di oppressione imposta o di sottomissione accettata, è la nascita dell’uomo responsabile capace di partecipare, alla pari con ogni altro, all’autogoverno della collettività”.
Un’idea di rivoluzione basata sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul possedere le mille parole, necessarie – anche collettivamente, da qui il bisogno di un partito – per costruire una società più giusta. Di fronte alla rivoluzione d’ottobre, pur sostenendo senza esitazioni i bolscevichi di Lenin, Rosa Luxemburg trovò subito parole forti di dissenso, se non di condanna politica, contestando lo scioglimento dell’Assemblea Costituente, la soppressione del diritto di voto per alcune categorie sociali e l’abolizione “delle più importanti garanzie democratiche di una sana vita pubblica e dell’attività politica delle masse lavoratrici: libertà di stampa, diritto di associazione e di riunione, che sono stati banditi per ogni avversario del regime sovietico”. [...]
La lettura dell’introduzione di Lelio Basso e dei testi che proponeva nella sua antologia mi rassicurava, mi dava speranza, indicava una prospettiva, attribuendo a quella donna, per me fino a quel momento sconosciuta, una lettura moderna e attuale del Marx che mi aveva entusiasmato invitando i proletari di tutto il mondo a unirsi. Sebbene non avessi ancora completato la lettura dell’antologia, già dalle prime pagine mi sentivo a tutti gli effetti un luxemburghiano.
Chi è stato Lelio Basso
Nato il 25 dicembre 1903 a Varazze (Savona), nel 1916 si trasferì a Milano, dove frequentò il Liceo Berchet e aderì al movimento giovanile socialista. Nei primi anni venti scrisse sui giornali della sinistra socialista e liberale e stabilì un rapporto di amicizia e di collaborazione con Piero Gobetti. Si avvicinò alle posizioni neoprotestanti della rivista «Conscientia» e collaborò con «Quarto Stato» di Nenni e Rosselli, mentre contribuiva all’organizzazione del movimento antifascista. Nel 1928 diresse la rivista «Pietre» e nell’aprile dello stesso anno fu arrestato e inviato al confino nell’isola di Ponza. Nel 1934 fu tra gli organizzatori del Centro interno socialista che guidò dal 1938 fino al secondo arresto dell’estate 1939. Liberato dal campo di internamento, alla fine del 1940 riprese i collegamenti con i gruppi socialisti clandestini e nel gennaio 1943 fu tra i promotori del Movimento di unità proletaria. Nel corso dello stesso anno, a seguito della unificazione del Mup con il ricostituito Psi, entrò nella direzione del nuovo Psiup di cui sarà eletto segretario nel gennaio 1947. Nel frattempo aveva fondato la rivista «Quarto Stato» ed era stato eletto all’Assemblea costituente dove svolse un ruolo di primo piano, in particolare con il contributo offerto alla formulazione degli Artt. 3 e 49 della Costituzione.
Dopo la sconfitta del Fronte popolare dell’aprile 1948, lasciò la segreteria e fu emarginato dal gruppo dirigente del Psi, appiattito su posizioni filo-staliniste. Nel 1953 fu confermato deputato alle elezioni politiche e negli anni successivi guidò la minoranza interna del Psi. Nel 1958 fondò la rivista «Problemi del socialismo». Alla formazione del primo governo organico di Centro-sinistra, nel 1963, partecipò alla nascita del nuovo Psiup. Nonostante fosse eletto presidente del nuovo partito, il suo impegno si orientò sempre più verso gli studi e l’organizzazione dei movimenti anti-imperialisti internazionali: nel 1964 fondò e diresse la rivista «International Socialist Journal/Revue International du socialisme» e fu relatore del Tribunale internazionale Russel per i crimini di guerra americani in Vietnam.
Nel 1968 lasciò la presidenza del Psiup per i contrasti sull’invasione sovietica della Cecoslovacchia e l’anno successivo fondò a Roma l’Istituto per lo studio della società contemporanea (Issoco) che nel 1973 diventerà la Fondazione intitolata a lui e alla moglie. Eletto al Senato come indipendente nelle liste Pci-Psiup, nel 1973 promosse il Tribunale Russell II sulla repressione in America Latina. Fondò la Lega per i diritti e la liberazione dei popoli e la Fondazione internazionale Lelio Basso. Nel luglio del 1976 fu protagonista della Conferenza internazionale di Algeri in cui viene promulgata la Dichiarazione universale dei diritti dei popoli. Morì a Roma il 16 dicembre 1978.
[cliccando sulle parole evidenziate in blu è possibile accedere alle pagine dedicate alla tematica richiamata, tratte dal sito della Fondazione che può essere visitato sempre cliccando sul testo evidenziato]
Che cosa sarebbe avvenuto se la socialdemocrazia tedesca avesse accettato e applicato la strategia di lotta suggerita da Rosa Luxemburg?
Per uno stralcio dall'introduzione all'Antologia
I tempi del web non sono compatibili con un documentario di un'ora ma... tra interviste, contributi filmati e testimonianze, i minuti scorrono velocemente e, in ultimo, risulteranno ben spesi.