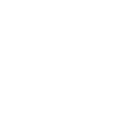da UNA ROSA NEL CUORE 4.3 La democrazia operaia
Nel 1970, a conferma dell’opportunità di realizzare per via parlamentare quello che Rosa Luxemburg aveva definito “il miglioramento della condizione del popolo lavoratore anche sul terreno dell’ordine esistente”, in Italia era stata adottata la Legge n. 300/1970, meglio conosciuta come Statuto dei Lavoratori. [...] Una legge che, ad oltre cinquanta anni dalla sua adozione, non è ancora del tutto compiutamente attuata e che, periodicamente, è sottoposta a tentativi di revisione o di neutralizzazione. Così come aveva lucidamente previsto Rosa Luxemburg nel suo confronto/scontro con Eduard Bernstein, la borghesia mette in discussione i suoi stessi equilibri democratici quando deve difendere i propri interessi e i propri privilegi e non è un caso se, in diverse fasi storiche, la classe operaia abbia dovuto intestarsi la lotta per la difesa della democrazia poiché “se per la borghesia la democrazia è diventata un elemento in parte superfluo, in parte di ostacolo, essa per la classe operaia, invece, è diventata necessaria e indispensabile. Necessaria, prima di tutto in quanto offre le forme politiche (autogoverno, diritto elettorale) che serviranno al proletariato nella sua opera di trasformazione della società borghese.
Ma anche indispensabile, perché solo in essa, nella lotta combattuta per la democrazia, nell’esercizio dei diritti democratici, il proletariato diviene cosciente dei propri interessi di classe e dei propri compiti strategici”.



Per la “nuova sinistra” i Consigli di Fabbrica rappresentavano il luogo della democrazia diretta, della possibilità di sperimentare, sul campo, la ricerca di forme nuove e originali per superare le contraddizioni già evidenti a inizio del “secolo breve” tra parlamentarismo e lotta di classe.
Ricorrendo di nuovo alla riflessione di Luciana Castellina “per Rosa Luxemburg la tematica consiliare era molto importante: costituiva la critica ai limiti del governo dei commissari del popolo in Russia senza tuttavia accettare l’ipotesi del parlamentarismo borghese. […] Noi fummo conquistati dall’ipotesi di costruire questa terza struttura, esercizio di un potere dal basso, capace di mediare tra partito e movimento e di riappropriarsi della gestione della società. […] È proprio a questa ipotesi consiliare che anche Gramsci lavorò ai tempi dell’Ordine Nuovo, assai più esaurientemente nei ‘Quaderni dal carcere’, riprendendo l’idea luxemburghiana di dar vita a forme permanenti di democrazia organizzata, espressione di un potere che, via via, si sostituisce a quello storicamente espropriato dallo stato. I Consigli di Fabbrica (e poi quelli di Zona) che cominciano a sorgere nel ’69, pur con tutti i loro limiti, a questa prospettiva intendevano rispondere: organismi politici e fuori dalla dimensione puramente sindacale, non istituiti per gestire la fabbrica ma, anzi, per contrastarne il suo modello di produzione”.