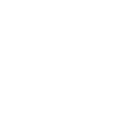Frigga Haug. 13 tesi di marxismo-femminismo
Questo report è stato pubblicato nel fascicolo 323 di Krise des Politischen, numero 3, 2017.
Cfr. il libro Wege des Marxismus-Feminismus, pubblicato come Argument 314, che documenta la maggior parte dei contributi.
Questa base per il pensiero e l’azione femminista marxista, formulata da Frigga Haug, è il risultato di un processo collettivo sviluppatosi attorno alle Conferenze Marx-Fem. Con un’introduzione di Frigga Haug.
Di fronte alle crisi profonde del capitalismo, con tutte le valvole di sicurezza aperte, per cui ogni crisi è solo un’intensificazione di quella precedente; con le crisi che colpiscono sempre più la vita quotidiana e le condizioni di vita che rendono più difficile fare progetti per un numero crescente di donne lasciate sole con un doppio fardello da portare, inviai un appello alle femministe marxiste conosciute nel movimento degli anni ’70, in riunioni, viaggi, docenze, per riflettere insieme sulla situazione. A nostro avviso era giunto il momento anche per le forze marxiste-femministe di incontrarsi a livello globale, così come il capitalismo e le crisi da esso prodotte sono diventati globali; in breve, era tempo per un’Internazionale marxista-femminista.
In una sola settimana, quaranta donne da tutte le parti del mondo risposero alla mia prima lettera circolare, con trentaquattro offerte di contributi al congresso che stavamo progettando. Questo primo congresso si è tenuto a Berlino dal 22 al 25 marzo 2015, con la partecipazione di oltre 500
donne provenienti da venti Paesi. Con l’intenzione di non fare di questa Internazionale un evento singolo e, allo stesso tempo, di ancorarla al futuro, avevo scritto dodici tesi per la plenaria conclusiva, che avevo “distillato” dai trentaquattro interventi, godendo del privilegio di conoscere già in anticipo i discorsi. Nella discussione della plenaria di Berlino, in cui sono state ascoltate le voci di molte donne, sono stati richiesti modifiche, miglioramenti ed approfondimenti di cui ho annotato la sintesi, includendola in una nuova versione delle tesi originali. C’è stato completo accordo sulla prosecuzione di questo percorso e il successivo congresso si è svolto a Vienna nel 2016, con la partecipazione, ancora una volta, di oltre 500 donne provenienti da trenta Paesi. Le tesi dovevano essere elaborate e migliorate in un’ulteriore discussione. Consideriamo le tesi come pietre angolari di ciò che abbiamo già raggiunto, come fondamenta, come voci per il nostro “manifesto” di femministe marxiste. Sono un bagaglio da viaggio, utile e pronto per essere usato. Molti suggerimenti avanzati alla Conferenza di Vienna (sulle tecnologie riproduttive, sull’inclusione delle culture indigene, sull’abilità) sono ancora in attesa di essere integrati.
Le tesi sono uno strumento di lavoro e l’assicurazione allo stesso tempo di ciò che siamo e di dove vogliamo arrivare, mentre sia il percorso sia l’obiettivo sono aperti al confronto e quindi al cambiamento.
13 tesi di marxismo-femminismo
I Il marxismo e il femminismo sono due facce della stessa medaglia, ma bisogna aggiungere che questa stessa moneta richiede una trasformazione. Il marxismo femminista si ancora saldamente all’eredità di Marx, e quindi al significato dell’analisi del lavoro sotto forma di lavoro salariato e
come forza trainante del movimento operaio. Tuttavia, nel tentativo di spostare anche le restanti attività femminili al centro dell’analisi, MF sposta la questione delle attività domestiche e non domestiche dai tentativi paralizzanti di pensarle completamente come una unica o, viceversa, come
completamente separate (dibattito sulla doppia economia, dibattito sul lavoro domestico), nella sfida fondamentale di occupare e trasformare il concetto di relazioni di produzione in questioni femministe.
II Si ipotizzano quindi due produzioni, quella della vita e quella dei mezzi di sussistenza, che sono collegate tra loro, ed è quindi possibile analizzare le pratiche individuali e il modo nel quale interagiscono. Questo apre un enorme campo di ricerca, in cui si possono indagare specifiche modalità di dominio e si possono ricercare possibilità di trasformazione in diversi modi storicamente e culturalmente specifici.
III È chiaro che le relazioni di genere sono relazioni di produzione, non un’aggiunta a esse. Tutte le pratiche, le norme, i valori, le autorità, le istituzioni, la lingua, la cultura, ecc. sono codificate nelle relazioni di genere. Questo presupposto rende la ricerca marxista femminista tanto prolifica quanto necessaria. La contemporaneità e la connessione all’interno delle relazioni globali e la simultanea eterogeneità di tipi storicamente concreti di oppressione delle donne richiedono che le attiviste internazionali mettano insieme le loro conoscenze ed esperienze.
IV Il marxismo non è utile per la società capitalista e le sue discipline accademiche che legittimano il dominio. Poiché il marxismo-femminismo presuppone che gli esseri umani costruiscano la propria storia (cioè costruiscano se stessi) – o, quando viene loro impedito di farlo, cerchino di conquistare
l’autodeterminazione –, non è adatto a una struttura di comando verticistica. Ciò rende possibili ricerche come il lavoro sulla memoria e l’analisi storico-critica di se stessi nel collettivo, quindi anche l’autocritica come forza di produzione.
V Il fatto che tutti i membri della società debbano partecipare alle relazioni di dominio per poter agire richiede uno studio concreto di quei nodi di dominio che paralizzano o incatenano il desiderio di cambiamento nel patriarcato capitalista. Le femministe hanno il vantaggio di avere meno privilegi che derivano dalla partecipazione al potere, quindi hanno meno da perdere, così come più esperienza nel vedere il mondo dal basso.
VI Tutti i membri della società capitalista subiscono il danno derivante da questi rapporti di dominio/sottomissione e fintanto che essi persisteranno nessuno vivrà in una società liberata. Nel nostro presente ci sono forme di dominio e violenza storicamente sedimentate, che non possono essere ridotte a un percorso di sviluppo continuo o a una contraddizione essenziale. Le forme selvagge di violenza (contro le donne), di brutalizzazione, di preparazione alla guerra, ecc. devono essere interpretate storicamente come differenti orrori derivanti da vecchie relazioni. Per le femministe marxiste queste relazioni violente devono essere una parte teorica e pratica fondamentale della loro lotta per la liberazione e per il raggiungimento dello status di soggetti al di sopra e contro il sottosviluppo uomo-umano. Ma la violenza non è solo espressione di relazioni tradizionali e antiquate, ma anche di relazioni che si producono nel presente. Ecco perché è necessaria una comprensione specifica della critica e dell’analisi che eviti gli essenzialismi. Le forme di violenza più brutali sono tornate come orrori da relazioni che pensavamo superate e che sono allo stesso tempo il prodotto delle relazioni attuali.
VII Il marxismo-femminismo prende posizione sul primato del movimento operaio come soggetto storico e agente di trasformazione. Portare il femminismo nel marxismo, e quindi cambiare entrambi, rende indispensabile una visione critica del marxismo tradizionale, che si riferisce esclusivamente al movimento operaio. Il marxismo è la critica di Marx all’economia politica + il movimento operaio, che ne fa la sua forza incomparabile. Ma ne rende anche visibili i limiti. Il destino della classe operaia mostra anche la sua incapacità di riconoscere e sviluppare ulteriormente questioni che trascendono l’orizzonte storico delle lotte di classe. Questo marxismo tradizionale non è ricettivo né alle nuove questioni femministe né a quelle dell’ecologia, quindi dobbiamo continuare a lavorarci. La ricchezza dei vari movimenti così come la ricchezza ancora non valorizzata del patrimonio culturale di Marx richiedono un lavoro continuo nel presente. Questa è una sfida per tutte le femministe marxiste, c’è un consenso su questo punto in quasi tutti i contributi.
VIII Il dibattito su razza, classe e sesso/genere (intersezionalità) dovrebbe essere approfondito. La connessione tra classe e sesso in tutte le società conquistate dal capitalismo deve essere investigata in dettaglio; ciò che appare come “questione razziale” deve essere risolto concretamente per
ciascuna società e cultura separatamente e deve essere correlato agli altri due tipi di oppressione. È necessario il pensiero non lineare.
IX Negli sconvolgimenti successivi alla crisi del fordismo, che si manifestano nella serie di crisi dell’economia rapidamente globalizzata e che spingono le persone in condizioni sempre più precarie, le donne sono tra quelle che ci rimettono di più, proprio come altre pratiche e gruppi emarginati.
X Lo smantellamento dello stato sociale occidentale in un’economia globalizzata lascia la cura della vita alle donne nel lavoro domestico non retribuito o nel lavoro a basso salario, qualcosa che può essere sperimentato nella catena di assistenza globale. Possiamo concepirla come una “crisi dell’assistenza”, come un’inevitabile conseguenza della società capitalista, che nello spostamento del suo centro economico verso i servizi produce un’estrazione di profitto, mentre coglie forme sempre più barbare di gestione delle crisi attraverso la creazione di livelli di valore.
XI Siamo accomunate dall’obiettivo di spostare la vita al centro delle nostre lotte e quindi delle lotte per il tempo collettivamente autodeterminato. Possiamo anche seguire il suggerimento di analizzare le crisi intorno alla vita come conseguenza di logiche di tempo disuguali all’interno di aree organizzate gerarchicamente. Come politica Haug suggerisce la prospettiva four-in-one, nella quale il processo decisionale non ha lo scopo di adattare le aree l’una all’altra, ma quello di liberarle dalla gerarchia attraverso la generalizzazione. Solo quando tutti saranno attivi in tutte le aree sarà possibile una società liberata.
XII Le nostre lotte sono dirette contro il dominio e radicalmente democratiche, il che richiede anche una politica dal basso. La nostra resistenza è situata culturalmente e temporalmente in modi diversi. Ma siamo con Marx, “per rovesciare tutti i rapporti in cui l’uomo è un essere degradato, schiavo,
abbandonato, disprezzato”. Organizzare un Congresso marxista-femminista e riflettere sulle nostre modalità di cooperazione e conflitto al suo interno è un modo per tradurre la nostra resistenza nello sviluppo di un movimento marxista-femminista costante.
XIII Le femministe marxiste non rimangono più nella posizione che il movimento operaio ha loro attribuito, in virtù della divisione del lavoro, come donne che incarnano la pace e sono responsabili del suo mantenimento, mentre gli uomini continuano a fare le guerre. Ci rifiutiamo di essere ridotte
a questa politica, ma vogliamo assumerci la responsabilità dell’insieme. Nell’attuale situazione globale, caratterizzata da crisi e guerre, consideriamo indispensabile il potere femminista. Abbiamo la responsabilità e abbiamo potenti possibilità.
I Il marxismo e il femminismo sono due facce della stessa medaglia, ma bisogna aggiungere che questa stessa moneta richiede una trasformazione. Il marxismo femminista si ancora saldamente all’eredità di Marx, e quindi al significato dell’analisi del lavoro sotto forma di lavoro salariato e
come forza trainante del movimento operaio. Tuttavia, nel tentativo di spostare anche le restanti attività femminili al centro dell’analisi, MF sposta la questione delle attività domestiche e non domestiche dai tentativi paralizzanti di pensarle completamente come una unica o, viceversa, come
completamente separate (dibattito sulla doppia economia, dibattito sul lavoro domestico), nella sfida fondamentale di occupare e trasformare il concetto di relazioni di produzione in questioni femministe.
II Si ipotizzano quindi due produzioni, quella della vita e quella dei mezzi di sussistenza, che sono collegate tra loro, ed è quindi possibile analizzare le pratiche individuali e il modo nel quale interagiscono. Questo apre un enorme campo di ricerca, in cui si possono indagare specifiche modalità di dominio e si possono ricercare possibilità di trasformazione in diversi modi storicamente e culturalmente specifici.
III È chiaro che le relazioni di genere sono relazioni di produzione, non un’aggiunta a esse. Tutte le pratiche, le norme, i valori, le autorità, le istituzioni, la lingua, la cultura, ecc. sono codificate nelle relazioni di genere. Questo presupposto rende la ricerca marxista femminista tanto prolifica quanto necessaria. La contemporaneità e la connessione all’interno delle relazioni globali e la simultanea eterogeneità di tipi storicamente concreti di oppressione delle donne richiedono che le attiviste internazionali mettano insieme le loro conoscenze ed esperienze.
IV Il marxismo non è utile per la società capitalista e le sue discipline accademiche che legittimano il dominio. Poiché il marxismo-femminismo presuppone che gli esseri umani costruiscano la propria storia (cioè costruiscano se stessi) – o, quando viene loro impedito di farlo, cerchino di conquistare
l’autodeterminazione –, non è adatto a una struttura di comando verticistica. Ciò rende possibili ricerche come il lavoro sulla memoria e l’analisi storico-critica di se stessi nel collettivo, quindi anche l’autocritica come forza di produzione.
V Il fatto che tutti i membri della società debbano partecipare alle relazioni di dominio per poter agire richiede uno studio concreto di quei nodi di dominio che paralizzano o incatenano il desiderio di cambiamento nel patriarcato capitalista. Le femministe hanno il vantaggio di avere meno privilegi che derivano dalla partecipazione al potere, quindi hanno meno da perdere, così come più esperienza nel vedere il mondo dal basso.
VI Tutti i membri della società capitalista subiscono il danno derivante da questi rapporti di dominio/sottomissione e fintanto che essi persisteranno nessuno vivrà in una società liberata. Nel nostro presente ci sono forme di dominio e violenza storicamente sedimentate, che non possono essere ridotte a un percorso di sviluppo continuo o a una contraddizione essenziale. Le forme selvagge di violenza (contro le donne), di brutalizzazione, di preparazione alla guerra, ecc. devono essere interpretate storicamente come differenti orrori derivanti da vecchie relazioni. Per le femministe marxiste queste relazioni violente devono essere una parte teorica e pratica fondamentale della loro lotta per la liberazione e per il raggiungimento dello status di soggetti al di sopra e contro il sottosviluppo uomo-umano. Ma la violenza non è solo espressione di relazioni tradizionali e antiquate, ma anche di relazioni che si producono nel presente. Ecco perché è necessaria una comprensione specifica della critica e dell’analisi che eviti gli essenzialismi. Le forme di violenza più brutali sono tornate come orrori da relazioni che pensavamo superate e che sono allo stesso tempo il prodotto delle relazioni attuali.
VII Il marxismo-femminismo prende posizione sul primato del movimento operaio come soggetto storico e agente di trasformazione. Portare il femminismo nel marxismo, e quindi cambiare entrambi, rende indispensabile una visione critica del marxismo tradizionale, che si riferisce esclusivamente al movimento operaio. Il marxismo è la critica di Marx all’economia politica + il movimento operaio, che ne fa la sua forza incomparabile. Ma ne rende anche visibili i limiti. Il destino della classe operaia mostra anche la sua incapacità di riconoscere e sviluppare ulteriormente questioni che trascendono l’orizzonte storico delle lotte di classe. Questo marxismo tradizionale non è ricettivo né alle nuove questioni femministe né a quelle dell’ecologia, quindi dobbiamo continuare a lavorarci. La ricchezza dei vari movimenti così come la ricchezza ancora non valorizzata del patrimonio culturale di Marx richiedono un lavoro continuo nel presente. Questa è una sfida per tutte le femministe marxiste, c’è un consenso su questo punto in quasi tutti i contributi.
VIII Il dibattito su razza, classe e sesso/genere (intersezionalità) dovrebbe essere approfondito. La connessione tra classe e sesso in tutte le società conquistate dal capitalismo deve essere investigata in dettaglio; ciò che appare come “questione razziale” deve essere risolto concretamente per
ciascuna società e cultura separatamente e deve essere correlato agli altri due tipi di oppressione. È necessario il pensiero non lineare.
IX Negli sconvolgimenti successivi alla crisi del fordismo, che si manifestano nella serie di crisi dell’economia rapidamente globalizzata e che spingono le persone in condizioni sempre più precarie, le donne sono tra quelle che ci rimettono di più, proprio come altre pratiche e gruppi emarginati.
X Lo smantellamento dello stato sociale occidentale in un’economia globalizzata lascia la cura della vita alle donne nel lavoro domestico non retribuito o nel lavoro a basso salario, qualcosa che può essere sperimentato nella catena di assistenza globale. Possiamo concepirla come una “crisi dell’assistenza”, come un’inevitabile conseguenza della società capitalista, che nello spostamento del suo centro economico verso i servizi produce un’estrazione di profitto, mentre coglie forme sempre più barbare di gestione delle crisi attraverso la creazione di livelli di valore.
XI Siamo accomunate dall’obiettivo di spostare la vita al centro delle nostre lotte e quindi delle lotte per il tempo collettivamente autodeterminato. Possiamo anche seguire il suggerimento di analizzare le crisi intorno alla vita come conseguenza di logiche di tempo disuguali all’interno di aree organizzate gerarchicamente. Come politica Haug suggerisce la prospettiva four-in-one, nella quale il processo decisionale non ha lo scopo di adattare le aree l’una all’altra, ma quello di liberarle dalla gerarchia attraverso la generalizzazione. Solo quando tutti saranno attivi in tutte le aree sarà possibile una società liberata.
XII Le nostre lotte sono dirette contro il dominio e radicalmente democratiche, il che richiede anche una politica dal basso. La nostra resistenza è situata culturalmente e temporalmente in modi diversi. Ma siamo con Marx, “per rovesciare tutti i rapporti in cui l’uomo è un essere degradato, schiavo,
abbandonato, disprezzato”. Organizzare un Congresso marxista-femminista e riflettere sulle nostre modalità di cooperazione e conflitto al suo interno è un modo per tradurre la nostra resistenza nello sviluppo di un movimento marxista-femminista costante.
XIII Le femministe marxiste non rimangono più nella posizione che il movimento operaio ha loro attribuito, in virtù della divisione del lavoro, come donne che incarnano la pace e sono responsabili del suo mantenimento, mentre gli uomini continuano a fare le guerre. Ci rifiutiamo di essere ridotte
a questa politica, ma vogliamo assumerci la responsabilità dell’insieme. Nell’attuale situazione globale, caratterizzata da crisi e guerre, consideriamo indispensabile il potere femminista. Abbiamo la responsabilità e abbiamo potenti possibilità.

Nata nel 1937 nel bacino della Ruhr, Frigga Haug è una delle sociologhe e filosofe che, dalla fine degli anni Sessanta in poi, hanno lasciato il segno nei passaggi cruciali del dibattito della sinistra e dei movimenti in Germania. Lo ha fatto nel superamento dell’ortodossia marxista, nel continuo contributo al pensiero e alla pratica del femminismo, nel campo della psicologia critica. Vicina alla Linke e componente del Comitato scientifico della Rosa-Luxemburg-Stiftung, si può dire che la sua elaborazione sia sempre stata in costruttivo dialogo con l’opera della rivoluzionaria ebreo-polacca.
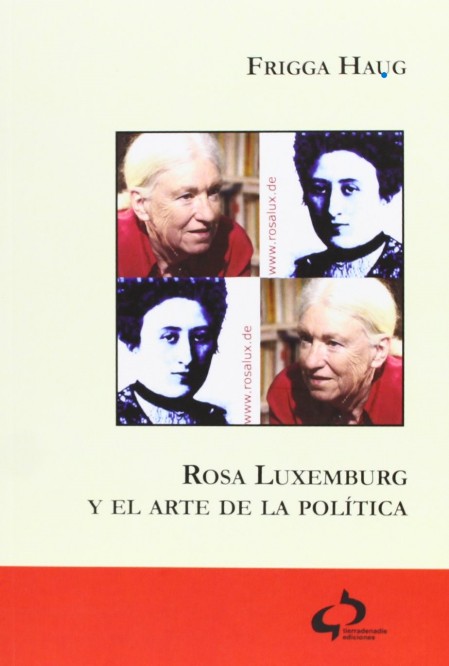
L'intervista a il manifesto del 15 gennaio 2019 Provare a essere realisti e rivoluzionari
di Beppe Caccia
Sei l’autrice che più di chiunque altro ha valorizzato il concetto luxemburghiano di “realismo rivoluzionario”. Puoi riassumerlo qui di nuovo? Come pensi sia possibile evitare che il richiamo al “realismo” diventi cinico adattamento all’esistente e quello alla “rivoluzione” pura fantasia ideologica?
Luxemburg lo definisce come rottura con ogni idea precedente di politica. Dà questo nome alla propria politica, forzando la contraddizione in un solo concetto e mettendola in tensione. Critica, al tempo stesso, i riformatori sociali che si concentrano solo sul miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e quelli che lottano unilateralmente per la rivoluzione in nome di un’altra, futura società. Se una politica socialista non fa delle condizioni di vita della classe operaia il suo punto di partenza, cioè se la situazione concreta della classe viene scavalcata con utopica esuberanza, la prospettiva socialista rimane una pura illusione. La politica socialista ha quindi bisogno tanto della lotta per migliorare le condizioni di vita, quanto della prospettiva di una società alternativa. Il punto cruciale per la Luxemburg è «come» connettere realpolitik e prospettiva rivoluzionaria. In linea generale, la sua proposta pratica è dare ai lavoratori la possibilità di plasmare la loro società, di governarla.
È da qui che il contesto del suo pensiero politico può essere decifrato. La politica diventa «politica dal basso», cioè determinata dall’idea che sono gli stessi lavoratori che devono prendere in mano la società. Questo è il suo incondizionato punto di contatto con i nuovi movimenti sociali, specialmente quelli femministi.
ll tuo seminale, volume del 2007, non è uno studio sul ruolo di Rosa Luxemburg nella storia del movimento operaio tedesco, né una sua biografia. Ma si concentra su alcuni nodi di quella che qualifichi come “l’arte della politica” della rivoluzionaria ebreo-polacca. Che cosa intendi con questa definizione? In che misura il riferimento all’ “arte” include quello a “poiesis” e “praxis”?
Descrivere la sua politica come arte non significa rinviare alle «belle arti» e contendere un posto in questo campo. Ma intendere la politica come un’opera che ha bisogno di studio, di senso del cambiamento e di fantasia. Un forte investimento intellettuale, capace di comprendere i rapporti di forza, e al tempo stesso di intuire in modo che il potere possa servire al benessere di chi sta in basso, in modo tale che le cose non rimangano tali e quali sono. Rosa Luxemburg pretende una politica che si adoperi per abolire se stessa come attività specialistica, così come i buoni insegnanti non vogliono che gli alunni rimangano tali, ma insegnano imparando essi stessi e trasformando gli alunni in insegnanti. In questo modo la politica deve rivedere criticamente le esperienze della storia umana e anticipare altre possibilità. Deve fondarsi sulla resistenza contro l’ordine dominante, e sull’accordo per l’istituzione di un nuovo ordine. Mostra la crisi e la guerra come catastrofi e, allo stesso tempo, vede come queste immani distruzioni dell’ordine tradizionale contengano anche la possibilità del cambiamento. Questa visione rende necessario individuare quali siano le risposte sbagliate che si danno a domande familiari, ad esempio se si è pro o contro il Parlamento, perché non pensa in termini di semplici opposti.
Descrivere la sua politica come arte non significa rinviare alle «belle arti» e contendere un posto in questo campo. Ma intendere la politica come un’opera che ha bisogno di studio, di senso del cambiamento e di fantasia. Un forte investimento intellettuale, capace di comprendere i rapporti di forza, e al tempo stesso di intuire in modo che il potere possa servire al benessere di chi sta in basso, in modo tale che le cose non rimangano tali e quali sono. Rosa Luxemburg pretende una politica che si adoperi per abolire se stessa come attività specialistica, così come i buoni insegnanti non vogliono che gli alunni rimangano tali, ma insegnano imparando essi stessi e trasformando gli alunni in insegnanti. In questo modo la politica deve rivedere criticamente le esperienze della storia umana e anticipare altre possibilità. Deve fondarsi sulla resistenza contro l’ordine dominante, e sull’accordo per l’istituzione di un nuovo ordine. Mostra la crisi e la guerra come catastrofi e, allo stesso tempo, vede come queste immani distruzioni dell’ordine tradizionale contengano anche la possibilità del cambiamento. Questa visione rende necessario individuare quali siano le risposte sbagliate che si danno a domande familiari, ad esempio se si è pro o contro il Parlamento, perché non pensa in termini di semplici opposti.
In questo momento “Ni Una Menos” è forse l’unico movimento globale. Non a caso è un movimento femminista. Sebbene Rosa Luxemburg non abbia prodotto specifici scritti sulla questione, tu hai sempre insistito sulla rilevanza del suo contributo per i movimenti delle donne. Come può il suo pensiero contribuire a questa nuova ondata femminista?
Rosa Luxemburg non ha scritto molto sulle donne. Poco rispetto al contributo della sua amica Clara Zetkin. Certo ha denunciato la «vita familiare filistea» della Germania, e ha descritto le donne proletarie come «le più povere tra i poveri e prive di diritti tra i senza-diritti», ma è difficile pensare a lei come femminista. Vi sono tuttavia, nel suo pensiero politico, punti essenziali di sostegno per un movimento di liberazione delle donne. Luxemburg insiste molto sull’auto-attivazione delle masse sfruttate, sul loro auto-sviluppo a partire dalla propria esperienza, in breve sul loro apprendimento dalla prassi collettiva. Non è forse un’indicazione preziosa per il movimento delle donne? Anche qui si tratta dell’autoemancipazione. Sono sempre stata convinta che sacrificare se stessi sia un atto e non un destino. Perché noi stessi portiamo spesso dentro di noi il dominio che vogliamo eliminare. Le donne devono prendere il loro destino nelle loro mani. La forza di cambiare la società patriarcale sorgerà solo dall’azione delle donne stesse. È questa una lezione ancora valida.
Rosa Luxemburg non ha scritto molto sulle donne. Poco rispetto al contributo della sua amica Clara Zetkin. Certo ha denunciato la «vita familiare filistea» della Germania, e ha descritto le donne proletarie come «le più povere tra i poveri e prive di diritti tra i senza-diritti», ma è difficile pensare a lei come femminista. Vi sono tuttavia, nel suo pensiero politico, punti essenziali di sostegno per un movimento di liberazione delle donne. Luxemburg insiste molto sull’auto-attivazione delle masse sfruttate, sul loro auto-sviluppo a partire dalla propria esperienza, in breve sul loro apprendimento dalla prassi collettiva. Non è forse un’indicazione preziosa per il movimento delle donne? Anche qui si tratta dell’autoemancipazione. Sono sempre stata convinta che sacrificare se stessi sia un atto e non un destino. Perché noi stessi portiamo spesso dentro di noi il dominio che vogliamo eliminare. Le donne devono prendere il loro destino nelle loro mani. La forza di cambiare la società patriarcale sorgerà solo dall’azione delle donne stesse. È questa una lezione ancora valida.
Come si porrebbe infine oggi Rosa Luxemburg di fronte al “ciclo politico reazionario” che sembra sopraffarci?
Lei stessa si è trovata in uno stato di profonda disperazione quando la classe operaia internazionale non si unì contro la guerra, ma ognuno appariva pronto a combattere solo per la propria «patria». Ma – con «ero, sono e sarò» – affermò che la resistenza al dominio avrebbe permesso alle persone di rendere sostenibile la propria società. La crescita delle destre non può che essere contrastata in questo modo ad ogni livello, attraverso un rinnovamento critico e autocritico degli strumenti del pensiero.
Lei stessa si è trovata in uno stato di profonda disperazione quando la classe operaia internazionale non si unì contro la guerra, ma ognuno appariva pronto a combattere solo per la propria «patria». Ma – con «ero, sono e sarò» – affermò che la resistenza al dominio avrebbe permesso alle persone di rendere sostenibile la propria società. La crescita delle destre non può che essere contrastata in questo modo ad ogni livello, attraverso un rinnovamento critico e autocritico degli strumenti del pensiero.